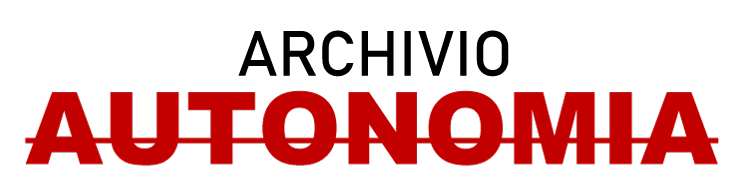Autonomie del Meridione
L’autonomia. Le autonomie
La storia dell’Autonomia nel Meridione negli anni ’70 del ventesimo secolo è stata un insieme frammentario di vicende che si intrecciarono intorno a eventi, lotte, grandi appuntamenti, storie personali e collettive dalle quali è nata un’esperienza storica radicata nelle lotte di classe. Per ricomporre questo ampio reticolo di lotte operaie e sociali, bisogna superare innanzi tutto la narrazione di un Sud come “macroregione indifferenziata” e scavare dentro i frammenti di quelle storie per abbandonare l’idea stessa di un Mezzogiorno ostaggio di “lazzari, plebaglia e lumpenproletariat” (a parte la presenza di una cosiddetta “borghesia illuminata”). A differenza di altre esperienze autonome territoriali italiane non si può parlare solo di “Autonomia operaia organizzata”, come sintesi e progetto delle diverse anime dell’Autonomia meridionale, per riassumerne la complessità perché la frammentazione organizzativa ne ha caratterizzato fin dal ’69 la geografia politica, con “fluide” esperienze organizzate di gruppi più o meno ampi, con un interscambio di militanti tra sigle e realtà territoriali, in percorsi continui di ricomposizione che segnarono profondamente i percorsi organizzativi. All’interno di una geografia industriale frammentata, con una classe operaia disseminata nelle “cattedrali del deserto”, l’autonomia delle lotte operaie ha avuto una sua consistenza, spesso rinforzata dall’azione degli emigranti che tornavano a casa in seguito a licenziamenti o per avere volontariamente abbandonato la fabbrica, ma quelle lotte operaie rappresentarono una parte del conflitto di classe meridionale degli anni ’70, in un rapporto di scambio e confronto continuo con le lotte urbane e contadine.
Alcuni settori dell’Autonomia meridionale, per riassumere quella diversità, proposero il concetto di “autonomia proletaria”, delineato in forma articolata nel 1976 nel numero di ottobre del giornale «Mò basta! Aizamm’a capa», nel quale si sosteneva la necessità non di «nuovo gruppo rivoluzionario» ma di un «cammino concreto della classe verso il comunismo», concetto vago, ma giustificato dal richiamo, tutto meridionale, alla storia del brigantaggio, alle rivolte contadine, alle occupazioni delle terre e a quell’«odio perenne contro lo Stato, agli atti di esasperazione selvaggi, assurdi e incomprensibili per il giornalismo liberale, di un popolo espropriato di tutto, della sua terra, della sua cultura». Autonomia proletaria era un concetto che serviva a delineare una composizione di classe sulla quale non poteva essere calata «ogni concezione che considera la classe come pura forza-lavoro, capitale variabile e non espressione soggettiva», per cui «rifiutiamo ogni concezione che porta alla necessità di una “coscienza esterna”, di un mediatore e interprete dei bisogni proletari». Si apriva così un orizzonte politico e militante originale, radicato nelle realtà del Sud, che «rivendica e considera interni alla classe gli atti di rivolta individuale, la ribellione contro il padrone, il prete, il sindacalista corrotto, il padre oppressivo, il preside autoritario e paternalista, il professore imbecille».
In quegli anni in cui avviene questa rottura con la tradizione della “sinistra storica”, l’autonomia proletaria meridionale opera una “frattura nella frattura”, rompendo il paradigma operaista con la valorizzazione dell’anomalia delle province meridionali, all’interno delle quali le specificità dell’operaismo venivano rimodulate rispetto alla composizione di classe e ai processi di produzione e valorizzazione delle comunità e dei territori che hanno generato fenomeni eterogenei, ciascuno con un suo spazio di espressione e una sua storia. È forse più corretto, allora, parlare al plurale di “autonomie meridionali”.

Le lotte del proletariato agrario meridionale dopo la seconda guerra mondiale e fino agli anni ’60, segnarono lo scontro di classe per la loro radicalità. A quel periodo risalgono le lotte, all’inizio spontanee poi organizzate, esplose nelle tradizionali aree del latifondo del Crotonese, del Tavoliere delle Puglie, dell’area rurale di Caltanissetta, con l’occupazione delle terre da parte dei braccianti disoccupati e con l’occupazione di terre a Melissa in Calabria, con l’uccisione di tre contadini che darà la spinta al varo della Riforma agraria del 1950. Negli anni immediatamente successivi alla Riforma la Sicilia diventerà terreno di scontro tra il proletariato agrario e lo Stato, alleato con la borghesia agraria, sul terreno del salario e dei contratti di lavoro. Gli scioperi degli operai della terra, gli scontri con le forze dell’ordine, i blocchi stradali, le barricate e la violenta repressione per un “ritorno all’ordine” saranno la cornice delle contrattazioni sindacali portate avanti dalle Camere del Lavoro. Gli obiettivi delle lotte raggiunti con i miglioramenti dei contratti di lavoro e delle tutele daranno un forte scossone agli equilibri sociali siciliani.
La rivolta di Avola del ’68 e i moti di Battipaglia del ’69, con morti e decine di feriti, segnarono la fuoriuscita della rabbia proletaria dagli argini delle rivendicazioni sindacali e dell’ egemonia politica del Partito comunista italiano, frattura che emergerà in modo drammatico nel luglio del 1970 con la rivolta di Reggio Calabria, quando l’incapacità politica del Partito comunista italiano e di molte formazioni extraparlamentari di sinistra, a parte Lotta continua, di leggerla come espressione di rabbia proletaria finita nelle maglie del neofascismo lascerà la sommossa popolare nelle mani dei fascisti locali capeggiati da Ciccio Franco.
In Calabria, tra il ’68 e il ’69, una serie di agitazioni nelle storiche aree di conflitto della regione evidenzierà la latitanza pressoché totale dei tradizionali partiti della sinistra e la nascita di piccoli gruppi “autonomi”, collettivi di piccole dimensioni e spesso non collegati tra loro ma attenti alle tematiche della lotta di classe di quella fase. Uno dei contributi più significativi fu quello degli intellettuali raccolti intorno al circolo “Mondo Nuovo” a Cosenza o al circolo culturale “25 aprile” di Castrovillari, a riviste e iniziative editoriali come i “Quaderni Calabresi”, punto di convergenza per elaborazioni di analisi e indicazioni politico-sociali provenienti dal resto della regione e da parte del Meridione. È da questi gruppi di dissenso che si svilupperà l’incontro fra operai, soprattutto gli edili delle città, e studenti in una Calabria che, come tutto il Sud di quel periodo, dimostrava di non essere “addormentata”.
I fatti di Reggio Calabria e le evidenti connivenze fra elementi della destra fascista reggina e le ‘ndrine determinarono una nuova consapevolezza nei movimenti di lotta della regione, in particolare dopo la strage di Gioia Tauro del 22 luglio del 1970 sul “treno del sole” Palermo-Torino e la tragica e sospetta morte di cinque anarchici del collettivo “La Baracca” di Reggio Calabria avvenuta in autostrada nel settembre dello stesso anno. Prezioso fu il lavoro di controinformazione degli anarchici che dimostrerà l’infiltrazione nel tessuto sociale del patto tra i neofascisti e la ‘ndrangheta, sia nella rivolta reggina come nel deragliamento del treno di Gioia Tauro.
Nell’ottobre del’72, durante una manifestazione nazionale sindacale a Reggio Calabria, in un grande corteo sfileranno delegazioni operaie del Nord con i proletari in lotta del Sud nonostante le direttive contrarie dei sindacati e gli attacchi di polizia e fascisti (alcune bombe verranno rinvenute sui binari dei treni che portavano gli operai del Nord alla manifestazione).

L’intervento politico dell’Autonomia meridionale non si concentrerà solo sulla fabbrica dell’operaio della catena di montaggio ma anche all’interno di spazi territoriali di città e campagne, utilizzando e sviluppando, soprattutto da parte degli autonomi napoletani, l’indicazione dell’operaismo di Raniero Panzieri di “aprire e tenere aperto il movimento”, ovvero tentare di attivare tutte le leve politico-sociali e di controinformazione per mantenere quanto più possibile aperto il punto d’attacco dei movimenti sociali, accumulare più forza possibile con le lotte sociali per allontanare il momento del riflusso, produrre nuove socialità, consolidare i movimenti di classe.
Nel 1964 a Napoli nasce il primo comitato dei baraccati, circa 20.000 proletari e sottoproletari che abitavano alloggi di fortuna o stanze d’albergo messe a disposizione dal Comune: uno spezzone di classe dalla composizione eterogenea dentro cui si ritrovavano, uniti dalle condizioni di miseria, operai licenziati, baraccati da generazioni, artigiani espulsi dal ciclo produttivo e “illegali”. Questo primo embrione di struttura autonoma, ancora lontana da qualsiasi ipotesi politico-organizzativa, favorì un lavoro di inchiesta, a partire dal ’65, sulle condizioni di classe di quelle realtà proletarie da parte di gruppi di intellettuali provenienti dal cattolicesimo del dissenso e dall’area socialista. Nel 1969 sempre a Napoli novecento famiglie daranno vita a un grande movimento di occupazioni delle case. Quelle strutture autogestite si saldavano con esperienze analoghe in quel periodo come a Torino, Milano, Roma, Cagliari e Palermo. Con la pratica dell’autogestione nasceranno le prime strutture territoriali di base, i comitati degli occupanti, che porteranno alla rottura con le forme tradizionali di rappresentanza politica e sindacale. Le strutture autogestite degli occupanti saranno l’embrione dei futuri Comitati di quartiere.
Quel movimento di occupazioni di case interesserà nel ’72 tutti i territori del Sud come il polo industriale di Taranto, come a Napoli e a Bari; piccoli aggregati familiari praticando una diffusa illegalità daranno vita a un fenomeno di massa che nel ’75 sfocerà in migliaia di stabili occupati. Le occupazioni si susseguiranno fino alla fine degli anni Settanta anche in luoghi lontani dalle grandi città, come a Potenza e a Foggia. Le occupazioni dei quartieri popolari saranno la base, negli anni a venire, della nascita del Movimento dei disoccupati.
Dal 1971, con il sorgere di diffuse e importanti lotte autonome operaie nel territorio napoletano, si svilupperà una singolare esperienza “emme-elle” con la nascita dell’organizzazione “Lotta di lunga durata”, un partito comunista marxista-leninista nato da una delle tante scissioni del Partito comunista d’Italia (m‑l). I fuoriusciti napoletani si riuniranno intorno alla carismatica figura di Gustavo Hermann, professore di fisica e figura di riferimento del movimento operaio napoletano, fondando anche un sindacato, l’Unione sindacale dei comitati di lotta (USCL), che in quegli anni si confronterà e tesserà legami con numerose altre realtà di lotta di fabbrica in tutta Italia, per approdare nel ’73 a Bologna al Convegno dei Comitati autonomi operai. In Puglia, tra la fine del ’68 e l’inizio del’69, i militanti del Movimento studentesco davanti ai cancelli delle fabbriche troveranno strutture organizzate dell’area marxista-leninista-maoista, fra cui il Circolo Lenin di Puglia che contendeva il primato della presenza politica regionale all’Unione dei comunisti italiani (m‑l), che diffondeva il giornale “Servire il Popolo”. A Brindisi tra l’estate del ’74 e la primavera del ’75 nasceranno gruppi legati all’Autonomia operaia organizzata (in particolare sulle tematiche riguardanti il proletariato giovanile) come l’area di Rosso e i Comitati autonomi operai romani di via dei Volsci.
A partire dalla rivolta di Reggio Calabria importanti saranno la presenza e l’iniziativa politica di Lotta continua che pubblicherà il foglio di agitazione “Mò che il tempo si avvicina”, giornale pensato per essere punto di riferimento e organo di informazione dei territori e delle città meridionali. Nel 1973 a Napoli Lotta continua promuoverà la Mensa dei bambini proletari di Montesanto, esperimento politico e sociale che riunì intellettuali e militanti, in un contesto sociale caratterizzato da altissima evasione scolastica, miseria e alta mortalità infantile. L’iniziativa rivolta ai bambini proletari del centro storico si allargherà, con il colera sopraggiunto pochi mesi dopo l’avvio delle attività, a quella sanitaria con la nascita del Centro di medicina popolare, un esempio originale di intervento e una rottura con la tradizionale azione politica della sinistra storica nei quartieri proletari. Con lo scioglimento, alla fine del ’76, dell’organizzazione la diaspora di quadri politici di alto profilo culturale e grandi doti organizzative darà vita a numerosi percorsi che contribuiranno alla nascita di molte realtà dell’Autonomia meridionale.
Negli anni ’70 le lotte ambientali saranno un importante terreno di scontro politico, economico e sociale sia con l’intervento contro la nocività degli impianti, come a Napoli e a Taranto, sia sul terreno occupazionale.
Nei territori meridionali sorgeranno basi militari, discariche di rifiuti tossici provenienti dagli impianti del nord Italia e stabilimenti nocivi, venduti alla popolazione come interventi per lo sviluppo e l’occupazione, come quelli per la lavorazione del fosgene che nel ’73 la Montedison sposta nell’ area di Brindisi. Saranno numerosi, nel corso degli anni, i disastri che segnarono la storia dei territori meridionali come quello del Petrolchimico di Manfredonia dove il 26 settembre 1976 esplose una colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca, riversando nell’aria 10 tonnellate di arsenico. La popolazione sarà avvertita soltanto molte ore dopo, la mobilitazione in città per la chiusura dell’impianto e la bonifica del territorio, rifiutando l’antico ricatto occupazionale tra lavoro, salute e ambiente, sarà forte e immediata e coinvolgerà militanti da tutta la regione. Numerosi saranno gli incidenti in questo tipo di impianti fino agli anni ’90 e la “questione ambientale” darà vita alla formazione di reti militanti organizzate che, soprattutto negli anni ottanta, si mobiliteranno con le lotte antinucleari, con i campeggi di lotta del 1983 e 1984, con la nascita del Coordinamento nazionale antimperialista e antinucleare.
A Napoli, dal ’69 al ’75, i Comitati di quartiere saranno le strutture di base dell’Autonomia, luoghi di incontro per militanti, studenti e proletariato urbano, presenti in quegli anni nelle lotte per il pane e per l’autoriduzione, nell’estate ’73 dell’epidemia del colera, con la pratica di forme di contropotere territoriale come la difesa di palazzi e quartieri contro gli “stacchi” dell’Enel. Quei nuclei eterogenei di organizzazione politica territoriale favoriranno processi autonomi organizzati che si salderanno con le lotte di un nutrito gruppo di avanguardie delle fabbriche disseminate sul territorio metropolitano.
Fin dai primi anni ’70 i militanti dei gruppi della sinistra extraparlamentare, in particolare di Lotta continua, e poi dell’ Autonomia meridionale dovranno confrontarsi con le realtà e i comportamenti di larghi strati di proletariato precario, “illegale”, non garantito; comportamenti di illegalità diffusa, soprattutto nei quartieri e territori del napoletano ma che interesseranno anche altri territori del Sud come Brindisi, Taranto e Bari, di migliaia di famiglie che “vivevano di microcriminalità”, come il contrabbando. Nasceranno prime embrionali esperienze organizzate. Nei quartieri e nelle celle delle carceri il proletariato “illegale” diventerà referente per organizzazioni come Lotta continua che istituirà una Commissione carceri all’ indomani del ciclo di rivolte del 1971, che fin dal 1969 e nel decennio successivo trasformeranno, all’inizio spontaneamente, le carceri in terreno di battaglia politica. Lotte e percorsi organizzati che nel 1974 daranno vita all’ organizzazione rivoluzionaria, i Nuclei armati proletari (Nap), che porrà come centrale la lotta dei “dannati della terra”, che praticherà azioni di propaganda armata come sequestri, espropri, ferimenti, azioni con l’uso anche dell’esplosivo, organizzerà evasioni. Presenti nelle carceri del Nord, come a Firenze, i Nap diventeranno soprattutto referenti per molti proletari precari e sottoproletari meridionali e in particolare a Napoli, nel carcere e in quartieri, come Forcella, dove il Comitato di quartiere darà vita a esperienze di lotta sul terreno dei prezzi politici delle merci, del salario sociale, con espropri di supermercati, di camion e furgoni di generi alimentari, poi distribuiti nel quartiere. Tra novembre del 1976 e febbraio del 1977 si svolgerà a Napoli il processo ai Nap, difesi dagli avvocati del Soccorso rosso, che vedrà un grande movimento di solidarietà di vasti settori del proletariato urbano e della sinistra rivoluzionaria napoletana mobilitarsi in una città militarizzata, con azioni come l’irruzione al Circolo della stampa. La breve e intensa storia dei Nap si può considerare conclusa il 1 luglio 1977 a Roma con l’uccisione di un militante e la cattura di altre due. In carcere molti militanti confluiranno nelle Brigate rosse.
L’ autonomia meridionale si mobiliterà sul terreno unificante dell’antifascismo. Numerose saranno le provocazioni fasciste, alcune molto gravi, e grandi saranno le risposte di massa di tutto il movimento rivoluzionario meridionale.
A Napoli nel maggio 1970 un commando fascista assalta la sede dell’USCL, ai Quartieri Spagnoli, la difesa sarà “con ogni mezzo necessario”, comprese le fiamme ossidriche usate dalle avanguardie operaie presenti nella sede; nella notte tra il 20 e 21 gennaio del 1972 Vincenzo de Waure, studente e militante antifascista, viene accoltellato e dato alle fiamme; gli attacchi dei fascisti colpiscono, in quegli anni, in modo indiscriminato, come il 17 giugno 1975 con l’uccisione con una molotov di Jolanda Palladino; il 30 settembre 1978 i fascisti aggrediscono a colpi di spranga un giovane militante comunista e un consigliere del Wwf, Claudio Miccoli, che morirà pochi giorni dopo.
Il 7 luglio 1972 a Salerno in uno scontro tra anarchici e fascisti morirà accoltellato Carlo Falvella, dirigente dell’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano, verrà arrestato l’anarchico Giovanni Marini. Il “caso Marini” e il processo che durerà fino al ’75 mobiliterà il movimento rivoluzionario italiano e Soccorso rosso.
A Bari i fascisti del Movimento sociale italiano (Msi) e del Fronte della gioventù attaccheranno le lotte del movimento studentesco e le lotte dei comitati proletari nei quartieri di Bari Vecchia, San Pasquale, Libertà e San Paolo.
Il 4 Giugno 1977 a Lecce grande mobilitazione del movimento rivoluzionario contro il comizio di Pino Rauti, esponente neonazista del Msi. La sera del 28 novembre 1977 a Bari i fascisti uccidono a coltellate, in uno scontro con militanti antifascisti, Benedetto Petrone, giovane esponente della Federazione giovanile comunista italiana; in risposta centinaia di manifestanti attaccheranno sedi, negozi e covi fascisti; il giorno successivo sfilerà un lungo corteo antifascista militante con i consigli di fabbrica della zona industriale, gli studenti, la popolazione di Bari Vecchia e tanti militanti arrivati dalla provincia; nel giorno dei funerali in diecimila attraverseranno la città militarizzata nonostante il divieto della questura, fischiando il comizio del Pci e scontrandosi con il suo servizio d’ordine. Nei mesi seguenti altre azioni contro i covi fascisti, le redazioni dei giornali di destra, le piccole e medie imprese, dove era diffuso il lavoro nero e minorile.
Nel dicembre del 1973 il “Movimento dei contadini e dei proletari del Mezzogiorno e delle isole” organizzerà a Cagliari un convegno sul tema “Mezzogiorno d’Italia e colonialismo”, con un’analisi sul ruolo e la posizione del Meridione nel quadro della struttura imperialistica internazionale. Gli atti e le conclusioni del convegno saranno dibattuti in particolare in Calabria dal gruppo dei “Quaderni Calabresi” e da alcuni circoli operaisti e leninisti in provincia di Catanzaro.
In quegli anni il dibattito sul Mezzogiorno si svilupperà parallelamente alle lotte di classe urbane e di fabbrica; si proverà a ridefinire “i nuovi termini della questione meridionale”, dal titolo di un volume del 1974 di numerosi intellettuali meridionali, tra cui E. Capecelatro, A. Carlo, N. Zitara e altri. Riflessioni che cercavano di assorbire la lezione “operaista” del volume di L. Ferrari Bravo e A. Serafini “Stato e Sottosviluppo, il caso del Mezzogiorno italiano” del 1972. Da quelle riflessioni emergerà, in particolare in ambienti calabresi, una rivisitazione ideologica della questione meridionale, che rileggerà il Sud come “colonia interna”, territorio di oppressione e sfruttamento, funzionali allo sviluppo capitalistico italiano. Maturerà in quegli anni in forma non organica ma progressivamente diffusa, all’interno dei collettivi politici sparsi nei territori del Sud, una linea interpretativa nuova che sosterrà sia l’analisi di un Sud colonizzato dal Capitale e dallo Stato al fine di smorzarne le capacità di insorgenza e sia una Autonomia meridionale con specifiche caratteristiche.
Nelle assemblee dell’Autonomia meridionale di Cosenza nell’ottobre 1976 e di Palermo nel gennaio 1978 emerse la necessità di superare la frantumazione delle iniziative disperse nei diversi territori meridionali per nuove forme di lotta e sintesi organizzative con due diverse progettualità: una, che facendo leva sulle specificità del Sud, porrà l’esigenza di non schiacciare il potenziale dell’autonomia meridionale con le vecchie forme organizzative “tardo-resistenziali”, superate e insufficienti per un rovesciamento radicale dei vecchi rapporti sociali e di produzione, l’altra invece sosterrà la necessità di costruire, pur in forme rinnovate, modalità di coordinamento tra le diverse realtà territoriali per una direzione politico-organizzativa del movimento.
Dal 1974 nell’area dei gruppi dell’Autonomia meridionale, impegnati nell’intervento territoriale in forme più o meno spontanee, si porrà il problema dell’uso della forza, della pratica della lotta armata, con la nascita in modo “disorganizzato” in tutto il Meridione di una tela di realtà militanti, con alcune discriminanti politiche come la scelta di non operare in clandestinità, essere sempre interni al movimento per costruire il contropotere proletario. Questo arcipelago di gruppi, che praticherà l’uso della forza a sostegno e difesa delle lotte territoriali e contro luoghi simbolici della presenza dello Stato nel Sud, si riunirà in una “non organizzazione” autonoma, i “Primi fuochi di guerriglia”, un progetto politico di una possibile Autonomia organizzata meridionale, per una struttura di raccordo delle disorganizzate realtà autonome, progetto che però non riuscirà a superare quella frammentazione strutturale del movimento rivoluzionario meridionale impegnato in una infinita discussione in tantissime riunioni informali nei territori, come a Palermo nel gennaio ’78 a latere dell’Assemblea dell’Autonomia Meridionale.
Anche nel sud Italia a metà del decennio con la crisi della sinistra extraparlamentare emergeranno nuove figure sociali, nuovi bisogni e comportamenti di classe, come il movimento femminista e il movimento dei circoli del proletariato giovanile che agiterà e praticherà tematiche e bisogni di una realtà giovanile meridionale schiacciata tra disoccupazione e lavoro precario.
Di grande impatto furono la critica e le pratiche delle lotte delle donne, numerosi furono i collettivi femministi che segnarono con le loro lotte una nuova stagione di movimento, in collegamento con le mobilitazioni nazionali come la campagna per il salario al lavoro domestico, inizialmente promossa dal gruppo “Lotta femminista”, nato nel ’71 per iniziativa di militanti dell’area di Potere operaio e scioltosi nel ’74 nei “Gruppi per il salario al lavoro domestico”. Questi gruppi, che rivendicheranno una propria autonomia e una separatezza rispetto a partiti e organizzazioni politiche, saranno presenti nelle grandi città e territori del Sud come a Napoli, Pescara, Salerno, Gela, Caltanissetta.
In Puglia nel ‘75 il Movimento Femminista Brindisino si mobiliterà in piazza per la prima volta aprendo la strada alla nascita del Collettivo Autonomia Femminista. Le campagne per il salario al lavoro domestico affiancheranno, negli stessi anni, le grandi battaglie per i diritti civili. La battaglia per il referendum sul divorzio e poi quella per l’aborto diventeranno temi centrali per tutti i gruppi femministi con grandi mobilitazioni come la manifestazione del 5 dicembre 1975 organizzata dal Movimento femminista brindisino.
La grande vitalità delle realtà dell’Autonomia meridionale, nonostante la povertà di mezzi, diede vita a riviste, pamphlet e giornali, con una loro diffusione locale e regionale grazie al “nomadismo militante” degli autonomi meridionali per paesi e province ovunque si manifestavano lotte operaie e sociali. Nell’ottobre del 1976 esce il primo numero di Mo basta! Aizam’a capa, foglio di quella Autonomia proletaria calabrese che si rifaceva alla storia del brigantaggio e all’estraneità del proletariato meridionale nei confronti dello Stato. I briganti, sottratti alla narrazione borghese che li voleva “banditi”, furono riproposti come partigiani del Sud, in grado di coagulare intorno alla propria rivolta forze sociali diverse di un Meridione occupato dall’esercito piemontese: “Li briganti” si chiamerà anche un altro giornale dell’autonomia calabrese, così come alla rilettura del brigantaggio si rifarà “Rossi rossi rossi…Briganti Rossi”, pubblicato nel febbraio 1978, all’indomani dell’arresto dei militanti dei Primi fuochi di guerriglia per l’assalto al centro di calcolo della Carical di Rende (Cosenza). Nei primi anni ottanta “Gramigna. Giornale comunista meridionale”, pubblicato a Vibo Valentia, informerà sull’intervento politico di numerosi collettivi operanti nelle altre regioni, fra cui la singolare esperienza del Comitato di lotta dei braccianti forestali di Potenza.
Proprio in Basilicata emergerà nel 1982 una significativa esperienza di informazione “dal basso”, attraverso il giornale “Lazzi e spilli” che raccoglierà l’area dei “sopravvissuti” agli arresti che coinvolsero i militanti e le militanti dei Primi fuochi di guerriglia.
Le difficoltà nel reperire fondi e tecnologia necessari per far funzionare radio libere di movimento furono spesso un problema difficilmente superabile per le realtà meridionali, come a Napoli con Radio Mariposa che rimase un progetto sulla carta. Un’esperienza significativa e isolata sarà invece Radio Casbah a Brindisi che entrerà in funzione nel 1985 diventando il punto di riferimento per le battaglie contro l’installazione della centrale nucleare a Torre Guaceto e quella a carbone di Cerano. A Napoli nell’ ambito delle lotte dei disoccupati organizzati l’ampio uso di strumenti comunicativi come volantini, “tazebao” e opuscoli sfocerà nel giornale “Banchi Nuovi”.
Il tentativo di costruire un progetto comunicativo collegato ai processi reali delle lotte prende forma nella stagione dell’autonomia napoletana alla fine degli anni ’70 quando la sede dell’Associazione Risveglio Napoli (ARN) diventa il luogo dove si riuniranno collettivi studenteschi, associazioni di familiari di detenuti, attivisti e militanti di comitati di quartiere e di collettivi territoriali riconducibili all’area dell’Autonomia Operaia. Nacque all’interno di quei locali il Centro di documentazione ARN che si proponeva di essere un punto di riferimento per le forze disperse dell’autonomia napoletana.
Nell’estate del 1981 la rivista autoprodotta “Black Out” si proporrà di “fornire all’interno del movimento di classe una lettura delle reali articolazioni strutturali ed istituzionali del potere, immediatamente traducibili in termini operativi” e, con il giornale “Vogliamo Tutto” di poco antecedente, costituì il tentativo degli autonomi napoletani di mantenere aperto un ambito di discussione e analisi in anni di repressione politico-giudiziaria iniziata in Italia il 7 aprile ’79 a Padova contro le forze dell’ Autonomia operaia organizzata. In quegli anni il Centro di documentazione ARN sarà anche un punto di incontro per quella parte dell’autonomia napoletana che si rifaceva all’analisi politica e alle proposte organizzative di fase, come il Movimento comunista organizzato, dei Collettivi politici veneti per il potere operaio avanzate a ridosso del violento attacco repressivo che quell’organizzazione subì l’ 11 marzo 1980.
Il terremoto del 23 novembre ’80 evidenzierà con più forza le questioni sociali, economiche, di classe del Mezzogiorno, emerse nel ciclo di lotte del decennio precedente e in una fase di violenta repressione e disgregazione organizzativa del movimento rivoluzionario. Nei territori del Sud colpiti dal sisma, in particolare a Napoli e nelle aree interne della Campania, saranno presenti fin dall’inizio i movimenti di lotta, dai disoccupati a quelli dei senza tetto; nella primavera del 1981 si terrà a Napoli una grande assemblea cittadina sul tema della casa e dei servizi sociali, dove si discuterà di un possibile progetto di città ridisegnata sui bisogni proletari e non sulle logiche e gli interessi capitalistici. Su quella stagione dell’autonomia napoletana si abbatterà un’inchiesta giudiziaria che crollerà nel giro di pochi mesi. Un corteo combattivo il 28 febbraio 1981, sfidando il divieto della questura, sfilerà per il centro di Napoli dietro lo striscione «Siamo tutti sovversivi».
In quei primi anni ’80 riprenderanno le lotte per la casa, nasceranno “basi rosse” nelle Vele di Secondigliano, nei quartieri periferici di Miano, Piscinola, Agnano e in numerose altre zone della città da dove si organizzavano le occupazioni di case sfitte di edilizia pubblica e privata, lotte che attaccate e ostacolate dagli apparati dello Stato e dalla camorra locale saranno radicate nel territorio perché espressione reale di una domanda legata ai bisogni sociali e collettivi di classe. Sarà soprattutto il CIM (Centro iniziativa marxista) in quel periodo ad assumere un ruolo di direzione politica dentro le lotte, che manterrà per un periodo rapporti politici con i Comitati autonomi operai romani.
Nel 1980 si organizzerà a Brindisi il primo campeggio antinucleare. Le lotte contro la produzione di energia prodotta dai combustibili fossili e dalle centrali nucleari saranno durissime e condotte in prima fila dagli autonomi pugliesi assieme al Coordinamento antinucleare e antimperialista.
Nel movimento rivoluzionario si discuterà animatamente sulle problematiche politiche di fase. L’area dell’autonomia vicina alle analisi della rivista “Metropoli” proporrà una lettura dei conflitti del dopo terremoto napoletano legandola ai movimenti che in quel periodo attraversavano molti territori europei sulle tematiche antinucleari, le occupazioni delle case e la battaglia per i primi centri sociali, il rifiuto della segregazione nei quartieri ghetto e le politiche neoliberiste.
Nel 1983 il Movimento promuoverà alcune importanti campagne di lotta, come quella contro l’articolo 90 del codice penale, precursore dell’attuale 41 bis, che istituiva un duro regime carcerario differenziato per i prigionieri politici. La manifestazione nazionale a Voghera, indetta insieme al Partito radicale, avvocati, giornalisti e singole associazioni verrà vietata; il corteo sarà caricato dalle forze di polizia, con una caccia all’uomo, trecento fermi e tre arresti.
Un’ altra campagna di lotta sarà la mobilitazione contro l’installazione a Comiso (Ragusa), dei missili Cruise, ordigni a testata nucleare. Tra la primavera e l’estate dell’83 le assemblee che si svolgeranno nel campeggio internazionale saranno intense e partecipate, le componenti dei collettivi autonomi si organizzeranno con iniziative di controinformazione nei territori circostanti.
Sempre nel 1983 si costituirà il Coordinamento Nazionale Antinucleare Antimperialista (CNNA) che sarà una importante realtà politica, organizzativa e di coordinamento delle lotte e delle mobilitazioni.
L’esperienza del CNNA per circa un decennio, dal Nord al Sud, riunirà le “vecchie” realtà autonome sopravvissute alla repressione e le “nuove” realtà di quegli anni, aiutando i collettivi sparsi sul territorio nazionale a rompere l’accerchiamento repressivo, promuovendo campagne di lotta nazionali contro il nucleare, contro la legge Craxi- Jervolino in materia di repressione sull’uso delle droghe, per le occupazioni di spazi abbandonati, per l’avvio di quella che sarà la stagione dei centri sociali, costituendo un ponte verso la nuova stagione di lotte degli anni Novanta.
L’intervento politico dell’Autonomia meridionale non si concentrerà solo sulla fabbrica dell’operaio della catena di montaggio ma anche all’interno di spazi territoriali di città e campagne, utilizzando e sviluppando, soprattutto da parte degli autonomi napoletani, l’indicazione dell’operaismo di Raniero Panzieri di “aprire e tenere aperto il movimento”, ovvero tentare di attivare tutte le leve politico-sociali e di controinformazione per mantenere quanto più possibile aperto il punto d’attacco dei movimenti sociali, accumulare più forza possibile con le lotte sociali per allontanare il momento del riflusso, produrre nuove socialità, consolidare i movimenti di classe.
Nel 1964 a Napoli nasce il primo comitato dei baraccati, circa 20.000 proletari e sottoproletari che abitavano alloggi di fortuna o stanze d’albergo messe a disposizione dal Comune: uno spezzone di classe dalla composizione eterogenea dentro cui si ritrovavano, uniti dalle condizioni di miseria, operai licenziati, baraccati da generazioni, artigiani espulsi dal ciclo produttivo e “illegali”. Questo primo embrione di struttura autonoma, ancora lontana da qualsiasi ipotesi politico-organizzativa, favorì un lavoro di inchiesta, a partire dal ’65, sulle condizioni di classe di quelle realtà proletarie da parte di gruppi di intellettuali provenienti dal cattolicesimo del dissenso e dall’area socialista. Nel 1969 sempre a Napoli novecento famiglie daranno vita a un grande movimento di occupazioni delle case. Quelle strutture autogestite si saldavano con esperienze analoghe in quel periodo come a Torino, Milano, Roma, Cagliari e Palermo. Con la pratica dell’autogestione nasceranno le prime strutture territoriali di base, i comitati degli occupanti, che porteranno alla rottura con le forme tradizionali di rappresentanza politica e sindacale. Le strutture autogestite degli occupanti saranno l’embrione dei futuri Comitati di quartiere.
Quel movimento di occupazioni di case interesserà nel ’72 tutti i territori del Sud come il polo industriale di Taranto, come a Napoli e a Bari; piccoli aggregati familiari praticando una diffusa illegalità daranno vita a un fenomeno di massa che nel ’75 sfocerà in migliaia di stabili occupati. Le occupazioni si susseguiranno fino alla fine degli anni Settanta anche in luoghi lontani dalle grandi città, come a Potenza e a Foggia. Le occupazioni dei quartieri popolari saranno la base, negli anni a venire, della nascita del Movimento dei disoccupati.
Dal 1971, con il sorgere di diffuse e importanti lotte autonome operaie nel territorio napoletano, si svilupperà una singolare esperienza “emme-elle” con la nascita dell’organizzazione “Lotta di lunga durata”, un partito comunista marxista-leninista nato da una delle tante scissioni del Partito comunista d’Italia (m‑l). I fuoriusciti napoletani si riuniranno intorno alla carismatica figura di Gustavo Hermann, professore di fisica e figura di riferimento del movimento operaio napoletano, fondando anche un sindacato, l’Unione sindacale dei comitati di lotta (USCL), che in quegli anni si confronterà e tesserà legami con numerose altre realtà di lotta di fabbrica in tutta Italia, per approdare nel ’73 a Bologna al Convegno dei Comitati autonomi operai. In Puglia, tra la fine del ’68 e l’inizio del’69, i militanti del Movimento studentesco davanti ai cancelli delle fabbriche troveranno strutture organizzate dell’area marxista-leninista-maoista, fra cui il Circolo Lenin di Puglia che contendeva il primato della presenza politica regionale all’Unione dei comunisti italiani (m‑l), che diffondeva il giornale “Servire il Popolo”. A Brindisi tra l’estate del ’74 e la primavera del ’75 nasceranno gruppi legati all’Autonomia operaia organizzata (in particolare sulle tematiche riguardanti il proletariato giovanile) come l’area di Rosso e i Comitati autonomi operai romani di via dei Volsci.
A partire dalla rivolta di Reggio Calabria importanti saranno la presenza e l’iniziativa politica di Lotta continua che pubblicherà il foglio di agitazione “Mò che il tempo si avvicina”, giornale pensato per essere punto di riferimento e organo di informazione dei territori e delle città meridionali. Nel 1973 a Napoli Lotta continua promuoverà la Mensa dei bambini proletari di Montesanto, esperimento politico e sociale che riunì intellettuali e militanti, in un contesto sociale caratterizzato da altissima evasione scolastica, miseria e alta mortalità infantile. L’iniziativa rivolta ai bambini proletari del centro storico si allargherà, con il colera sopraggiunto pochi mesi dopo l’avvio delle attività, a quella sanitaria con la nascita del Centro di medicina popolare, un esempio originale di intervento e una rottura con la tradizionale azione politica della sinistra storica nei quartieri proletari. Con lo scioglimento, alla fine del ’76, dell’organizzazione la diaspora di quadri politici di alto profilo culturale e grandi doti organizzative darà vita a numerosi percorsi che contribuiranno alla nascita di molte realtà dell’Autonomia meridionale.
Negli anni ’70 le lotte ambientali saranno un importante terreno di scontro politico, economico e sociale sia con l’intervento contro la nocività degli impianti, come a Napoli e a Taranto, sia sul terreno occupazionale.
Nei territori meridionali sorgeranno basi militari, discariche di rifiuti tossici provenienti dagli impianti del nord Italia e stabilimenti nocivi, venduti alla popolazione come interventi per lo sviluppo e l’occupazione, come quelli per la lavorazione del fosgene che nel ’73 la Montedison sposta nell’ area di Brindisi. Saranno numerosi, nel corso degli anni, i disastri che segnarono la storia dei territori meridionali come quello del Petrolchimico di Manfredonia dove il 26 settembre 1976 esplose una colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca, riversando nell’aria 10 tonnellate di arsenico. La popolazione sarà avvertita soltanto molte ore dopo, la mobilitazione in città per la chiusura dell’impianto e la bonifica del territorio, rifiutando l’antico ricatto occupazionale tra lavoro, salute e ambiente, sarà forte e immediata e coinvolgerà militanti da tutta la regione. Numerosi saranno gli incidenti in questo tipo di impianti fino agli anni ’90 e la “questione ambientale” darà vita alla formazione di reti militanti organizzate che, soprattutto negli anni ottanta, si mobiliteranno con le lotte antinucleari, con i campeggi di lotta del 1983 e 1984, con la nascita del Coordinamento nazionale antimperialista e antinucleare.
A Napoli, dal ’69 al ’75, i Comitati di quartiere saranno le strutture di base dell’Autonomia, luoghi di incontro per militanti, studenti e proletariato urbano, presenti in quegli anni nelle lotte per il pane e per l’autoriduzione, nell’estate ’73 dell’epidemia del colera, con la pratica di forme di contropotere territoriale come la difesa di palazzi e quartieri contro gli “stacchi” dell’Enel. Quei nuclei eterogenei di organizzazione politica territoriale favoriranno processi autonomi organizzati che si salderanno con le lotte di un nutrito gruppo di avanguardie delle fabbriche disseminate sul territorio metropolitano.
Fin dai primi anni ’70 i militanti dei gruppi della sinistra extraparlamentare, in particolare di Lotta continua, e poi dell’ Autonomia meridionale dovranno confrontarsi con le realtà e i comportamenti di larghi strati di proletariato precario, “illegale”, non garantito; comportamenti di illegalità diffusa, soprattutto nei quartieri e territori del napoletano ma che interesseranno anche altri territori del Sud come Brindisi, Taranto e Bari, di migliaia di famiglie che “vivevano di microcriminalità”, come il contrabbando. Nasceranno prime embrionali esperienze organizzate. Nei quartieri e nelle celle delle carceri il proletariato “illegale” diventerà referente per organizzazioni come Lotta continua che istituirà una Commissione carceri all’ indomani del ciclo di rivolte del 1971, che fin dal 1969 e nel decennio successivo trasformeranno, all’inizio spontaneamente, le carceri in terreno di battaglia politica. Lotte e percorsi organizzati che nel 1974 daranno vita all’ organizzazione rivoluzionaria, i Nuclei armati proletari (Nap), che porrà come centrale la lotta dei “dannati della terra”, che praticherà azioni di propaganda armata come sequestri, espropri, ferimenti, azioni con l’uso anche dell’esplosivo, organizzerà evasioni. Presenti nelle carceri del Nord, come a Firenze, i Nap diventeranno soprattutto referenti per molti proletari precari e sottoproletari meridionali e in particolare a Napoli, nel carcere e in quartieri, come Forcella, dove il Comitato di quartiere darà vita a esperienze di lotta sul terreno dei prezzi politici delle merci, del salario sociale, con espropri di supermercati, di camion e furgoni di generi alimentari, poi distribuiti nel quartiere. Tra novembre del 1976 e febbraio del 1977 si svolgerà a Napoli il processo ai Nap, difesi dagli avvocati del Soccorso rosso, che vedrà un grande movimento di solidarietà di vasti settori del proletariato urbano e della sinistra rivoluzionaria napoletana mobilitarsi in una città militarizzata, con azioni come l’irruzione al Circolo della stampa. La breve e intensa storia dei Nap si può considerare conclusa il 1 luglio 1977 a Roma con l’uccisione di un militante e la cattura di altre due. In carcere molti militanti confluiranno nelle Brigate rosse.
L’ autonomia meridionale si mobiliterà sul terreno unificante dell’antifascismo. Numerose saranno le provocazioni fasciste, alcune molto gravi, e grandi saranno le risposte di massa di tutto il movimento rivoluzionario meridionale.
A Napoli nel maggio 1970 un commando fascista assalta la sede dell’USCL, ai Quartieri Spagnoli, la difesa sarà “con ogni mezzo necessario”, comprese le fiamme ossidriche usate dalle avanguardie operaie presenti nella sede; nella notte tra il 20 e 21 gennaio del 1972 Vincenzo de Waure, studente e militante antifascista, viene accoltellato e dato alle fiamme; gli attacchi dei fascisti colpiscono, in quegli anni, in modo indiscriminato, come il 17 giugno 1975 con l’uccisione con una molotov di Jolanda Palladino; il 30 settembre 1978 i fascisti aggrediscono a colpi di spranga un giovane militante comunista e un consigliere del Wwf, Claudio Miccoli, che morirà pochi giorni dopo.
Il 7 luglio 1972 a Salerno in uno scontro tra anarchici e fascisti morirà accoltellato Carlo Falvella, dirigente dell’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano, verrà arrestato l’anarchico Giovanni Marini. Il “caso Marini” e il processo che durerà fino al ’75 mobiliterà il movimento rivoluzionario italiano e Soccorso rosso.
A Bari i fascisti del Movimento sociale italiano (Msi) e del Fronte della gioventù attaccheranno le lotte del movimento studentesco e le lotte dei comitati proletari nei quartieri di Bari Vecchia, San Pasquale, Libertà e San Paolo.
Il 4 Giugno 1977 a Lecce grande mobilitazione del movimento rivoluzionario contro il comizio di Pino Rauti, esponente neonazista del Msi. La sera del 28 novembre 1977 a Bari i fascisti uccidono a coltellate, in uno scontro con militanti antifascisti, Benedetto Petrone, giovane esponente della Federazione giovanile comunista italiana; in risposta centinaia di manifestanti attaccheranno sedi, negozi e covi fascisti; il giorno successivo sfilerà un lungo corteo antifascista militante con i consigli di fabbrica della zona industriale, gli studenti, la popolazione di Bari Vecchia e tanti militanti arrivati dalla provincia; nel giorno dei funerali in diecimila attraverseranno la città militarizzata nonostante il divieto della questura, fischiando il comizio del Pci e scontrandosi con il suo servizio d’ordine. Nei mesi seguenti altre azioni contro i covi fascisti, le redazioni dei giornali di destra, le piccole e medie imprese, dove era diffuso il lavoro nero e minorile.
Nel dicembre del 1973 il “Movimento dei contadini e dei proletari del Mezzogiorno e delle isole” organizzerà a Cagliari un convegno sul tema “Mezzogiorno d’Italia e colonialismo”, con un’analisi sul ruolo e la posizione del Meridione nel quadro della struttura imperialistica internazionale. Gli atti e le conclusioni del convegno saranno dibattuti in particolare in Calabria dal gruppo dei “Quaderni Calabresi” e da alcuni circoli operaisti e leninisti in provincia di Catanzaro.
In quegli anni il dibattito sul Mezzogiorno si svilupperà parallelamente alle lotte di classe urbane e di fabbrica; si proverà a ridefinire “i nuovi termini della questione meridionale”, dal titolo di un volume del 1974 di numerosi intellettuali meridionali, tra cui E. Capecelatro, A. Carlo, N. Zitara e altri. Riflessioni che cercavano di assorbire la lezione “operaista” del volume di L. Ferrari Bravo e A. Serafini “Stato e Sottosviluppo, il caso del Mezzogiorno italiano” del 1972. Da quelle riflessioni emergerà, in particolare in ambienti calabresi, una rivisitazione ideologica della questione meridionale, che rileggerà il Sud come “colonia interna”, territorio di oppressione e sfruttamento, funzionali allo sviluppo capitalistico italiano. Maturerà in quegli anni in forma non organica ma progressivamente diffusa, all’interno dei collettivi politici sparsi nei territori del Sud, una linea interpretativa nuova che sosterrà sia l’analisi di un Sud colonizzato dal Capitale e dallo Stato al fine di smorzarne le capacità di insorgenza e sia una Autonomia meridionale con specifiche caratteristiche.
Nelle assemblee dell’Autonomia meridionale di Cosenza nell’ottobre 1976 e di Palermo nel gennaio 1978 emerse la necessità di superare la frantumazione delle iniziative disperse nei diversi territori meridionali per nuove forme di lotta e sintesi organizzative con due diverse progettualità: una, che facendo leva sulle specificità del Sud, porrà l’esigenza di non schiacciare il potenziale dell’autonomia meridionale con le vecchie forme organizzative “tardo-resistenziali”, superate e insufficienti per un rovesciamento radicale dei vecchi rapporti sociali e di produzione, l’altra invece sosterrà la necessità di costruire, pur in forme rinnovate, modalità di coordinamento tra le diverse realtà territoriali per una direzione politico-organizzativa del movimento.
Dal 1974 nell’area dei gruppi dell’Autonomia meridionale, impegnati nell’intervento territoriale in forme più o meno spontanee, si porrà il problema dell’uso della forza, della pratica della lotta armata, con la nascita in modo “disorganizzato” in tutto il Meridione di una tela di realtà militanti, con alcune discriminanti politiche come la scelta di non operare in clandestinità, essere sempre interni al movimento per costruire il contropotere proletario. Questo arcipelago di gruppi, che praticherà l’uso della forza a sostegno e difesa delle lotte territoriali e contro luoghi simbolici della presenza dello Stato nel Sud, si riunirà in una “non organizzazione” autonoma, i “Primi fuochi di guerriglia”, un progetto politico di una possibile Autonomia organizzata meridionale, per una struttura di raccordo delle disorganizzate realtà autonome, progetto che però non riuscirà a superare quella frammentazione strutturale del movimento rivoluzionario meridionale impegnato in una infinita discussione in tantissime riunioni informali nei territori, come a Palermo nel gennaio ’78 a latere dell’Assemblea dell’Autonomia Meridionale.
Anche nel sud Italia a metà del decennio con la crisi della sinistra extraparlamentare emergeranno nuove figure sociali, nuovi bisogni e comportamenti di classe, come il movimento femminista e il movimento dei circoli del proletariato giovanile che agiterà e praticherà tematiche e bisogni di una realtà giovanile meridionale schiacciata tra disoccupazione e lavoro precario.
Di grande impatto furono la critica e le pratiche delle lotte delle donne, numerosi furono i collettivi femministi che segnarono con le loro lotte una nuova stagione di movimento, in collegamento con le mobilitazioni nazionali come la campagna per il salario al lavoro domestico, inizialmente promossa dal gruppo “Lotta femminista”, nato nel ’71 per iniziativa di militanti dell’area di Potere operaio e scioltosi nel ’74 nei “Gruppi per il salario al lavoro domestico”. Questi gruppi, che rivendicheranno una propria autonomia e una separatezza rispetto a partiti e organizzazioni politiche, saranno presenti nelle grandi città e territori del Sud come a Napoli, Pescara, Salerno, Gela, Caltanissetta.
In Puglia nel ‘75 il Movimento Femminista Brindisino si mobiliterà in piazza per la prima volta aprendo la strada alla nascita del Collettivo Autonomia Femminista. Le campagne per il salario al lavoro domestico affiancheranno, negli stessi anni, le grandi battaglie per i diritti civili. La battaglia per il referendum sul divorzio e poi quella per l’aborto diventeranno temi centrali per tutti i gruppi femministi con grandi mobilitazioni come la manifestazione del 5 dicembre 1975 organizzata dal Movimento femminista brindisino.
La grande vitalità delle realtà dell’Autonomia meridionale, nonostante la povertà di mezzi, diede vita a riviste, pamphlet e giornali, con una loro diffusione locale e regionale grazie al “nomadismo militante” degli autonomi meridionali per paesi e province ovunque si manifestavano lotte operaie e sociali. Nell’ottobre del 1976 esce il primo numero di Mo basta! Aizam’a capa, foglio di quella Autonomia proletaria calabrese che si rifaceva alla storia del brigantaggio e all’estraneità del proletariato meridionale nei confronti dello Stato. I briganti, sottratti alla narrazione borghese che li voleva “banditi”, furono riproposti come partigiani del Sud, in grado di coagulare intorno alla propria rivolta forze sociali diverse di un Meridione occupato dall’esercito piemontese: “Li briganti” si chiamerà anche un altro giornale dell’autonomia calabrese, così come alla rilettura del brigantaggio si rifarà “Rossi rossi rossi…Briganti Rossi”, pubblicato nel febbraio 1978, all’indomani dell’arresto dei militanti dei Primi fuochi di guerriglia per l’assalto al centro di calcolo della Carical di Rende (Cosenza). Nei primi anni ottanta “Gramigna. Giornale comunista meridionale”, pubblicato a Vibo Valentia, informerà sull’intervento politico di numerosi collettivi operanti nelle altre regioni, fra cui la singolare esperienza del Comitato di lotta dei braccianti forestali di Potenza.
Proprio in Basilicata emergerà nel 1982 una significativa esperienza di informazione “dal basso”, attraverso il giornale “Lazzi e spilli” che raccoglierà l’area dei “sopravvissuti” agli arresti che coinvolsero i militanti e le militanti dei Primi fuochi di guerriglia.
Le difficoltà nel reperire fondi e tecnologia necessari per far funzionare radio libere di movimento furono spesso un problema difficilmente superabile per le realtà meridionali, come a Napoli con Radio Mariposa che rimase un progetto sulla carta. Un’esperienza significativa e isolata sarà invece Radio Casbah a Brindisi che entrerà in funzione nel 1985 diventando il punto di riferimento per le battaglie contro l’installazione della centrale nucleare a Torre Guaceto e quella a carbone di Cerano. A Napoli nell’ ambito delle lotte dei disoccupati organizzati l’ampio uso di strumenti comunicativi come volantini, “tazebao” e opuscoli sfocerà nel giornale “Banchi Nuovi”.
Il tentativo di costruire un progetto comunicativo collegato ai processi reali delle lotte prende forma nella stagione dell’autonomia napoletana alla fine degli anni ’70 quando la sede dell’Associazione Risveglio Napoli (ARN) diventa il luogo dove si riuniranno collettivi studenteschi, associazioni di familiari di detenuti, attivisti e militanti di comitati di quartiere e di collettivi territoriali riconducibili all’area dell’Autonomia Operaia. Nacque all’interno di quei locali il Centro di documentazione ARN che si proponeva di essere un punto di riferimento per le forze disperse dell’autonomia napoletana.
Nell’estate del 1981 la rivista autoprodotta “Black Out” si proporrà di “fornire all’interno del movimento di classe una lettura delle reali articolazioni strutturali ed istituzionali del potere, immediatamente traducibili in termini operativi” e, con il giornale “Vogliamo Tutto” di poco antecedente, costituì il tentativo degli autonomi napoletani di mantenere aperto un ambito di discussione e analisi in anni di repressione politico-giudiziaria iniziata in Italia il 7 aprile ’79 a Padova contro le forze dell’ Autonomia operaia organizzata. In quegli anni il Centro di documentazione ARN sarà anche un punto di incontro per quella parte dell’autonomia napoletana che si rifaceva all’analisi politica e alle proposte organizzative di fase, come il Movimento comunista organizzato, dei Collettivi politici veneti per il potere operaio avanzate a ridosso del violento attacco repressivo che quell’organizzazione subì l’ 11 marzo 1980.
Il terremoto del 23 novembre ’80 evidenzierà con più forza le questioni sociali, economiche, di classe del Mezzogiorno, emerse nel ciclo di lotte del decennio precedente e in una fase di violenta repressione e disgregazione organizzativa del movimento rivoluzionario. Nei territori del Sud colpiti dal sisma, in particolare a Napoli e nelle aree interne della Campania, saranno presenti fin dall’inizio i movimenti di lotta, dai disoccupati a quelli dei senza tetto; nella primavera del 1981 si terrà a Napoli una grande assemblea cittadina sul tema della casa e dei servizi sociali, dove si discuterà di un possibile progetto di città ridisegnata sui bisogni proletari e non sulle logiche e gli interessi capitalistici. Su quella stagione dell’autonomia napoletana si abbatterà un’inchiesta giudiziaria che crollerà nel giro di pochi mesi. Un corteo combattivo il 28 febbraio 1981, sfidando il divieto della questura, sfilerà per il centro di Napoli dietro lo striscione «Siamo tutti sovversivi».
In quei primi anni ’80 riprenderanno le lotte per la casa, nasceranno “basi rosse” nelle Vele di Secondigliano, nei quartieri periferici di Miano, Piscinola, Agnano e in numerose altre zone della città da dove si organizzavano le occupazioni di case sfitte di edilizia pubblica e privata, lotte che attaccate e ostacolate dagli apparati dello Stato e dalla camorra locale saranno radicate nel territorio perché espressione reale di una domanda legata ai bisogni sociali e collettivi di classe. Sarà soprattutto il CIM (Centro iniziativa marxista) in quel periodo ad assumere un ruolo di direzione politica dentro le lotte, che manterrà per un periodo rapporti politici con i Comitati autonomi operai romani.
Nel 1980 si organizzerà a Brindisi il primo campeggio antinucleare. Le lotte contro la produzione di energia prodotta dai combustibili fossili e dalle centrali nucleari saranno durissime e condotte in prima fila dagli autonomi pugliesi assieme al Coordinamento antinucleare e antimperialista.
Nel movimento rivoluzionario si discuterà animatamente sulle problematiche politiche di fase. L’area dell’autonomia vicina alle analisi della rivista “Metropoli” proporrà una lettura dei conflitti del dopo terremoto napoletano legandola ai movimenti che in quel periodo attraversavano molti territori europei sulle tematiche antinucleari, le occupazioni delle case e la battaglia per i primi centri sociali, il rifiuto della segregazione nei quartieri ghetto e le politiche neoliberiste.
Nel 1983 il Movimento promuoverà alcune importanti campagne di lotta, come quella contro l’articolo 90 del codice penale, precursore dell’attuale 41 bis, che istituiva un duro regime carcerario differenziato per i prigionieri politici. La manifestazione nazionale a Voghera, indetta insieme al Partito radicale, avvocati, giornalisti e singole associazioni verrà vietata; il corteo sarà caricato dalle forze di polizia, con una caccia all’uomo, trecento fermi e tre arresti.
Un’ altra campagna di lotta sarà la mobilitazione contro l’installazione a Comiso (Ragusa), dei missili Cruise, ordigni a testata nucleare. Tra la primavera e l’estate dell’83 le assemblee che si svolgeranno nel campeggio internazionale saranno intense e partecipate, le componenti dei collettivi autonomi si organizzeranno con iniziative di controinformazione nei territori circostanti.
Sempre nel 1983 si costituirà il Coordinamento Nazionale Antinucleare Antimperialista (CNNA) che sarà una importante realtà politica, organizzativa e di coordinamento delle lotte e delle mobilitazioni.
L’esperienza del CNNA per circa un decennio, dal Nord al Sud, riunirà le “vecchie” realtà autonome sopravvissute alla repressione e le “nuove” realtà di quegli anni, aiutando i collettivi sparsi sul territorio nazionale a rompere l’accerchiamento repressivo, promuovendo campagne di lotta nazionali contro il nucleare, contro la legge Craxi- Jervolino in materia di repressione sull’uso delle droghe, per le occupazioni di spazi abbandonati, per l’avvio di quella che sarà la stagione dei centri sociali, costituendo un ponte verso la nuova stagione di lotte degli anni Novanta.

APPELLO
Facciamo appello alle compagne e ai compagni che hanno condiviso la nostra storia a tutti i livelli e che vogliono arricchire questo sito con un loro contributo scritto/orale/video, raccontando le proprie esperienze, di contattarci a questo indirizzo email:
autonomiedelmeridione@archivioautonomia.it