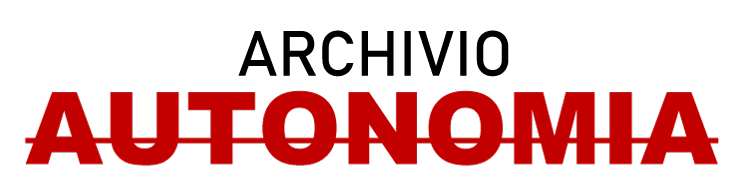Collettivi Politici Veneti per il Potere Operaio


A seguito dello scioglimento, al convegno di Rosolina (Rovigo) nel 1973, di Potere Operaio, gruppo della sinistra extraparlamentare italiana nei primi anni ’70, i militanti della sede di Padova dopo un periodo di dibattito politico-organizzativo sul “che fare” daranno vita nella seconda metà del 1974, nella loro stragrande maggioranza, al progetto politico comunista dei Collettivi Politici Padovani per il Potere Operaio. Nella prima circolare interna vengono poste le basi politico-organizzative del nuovo progetto con lo scopo di “costruire nuclei di combattenti comunisti omogenei su tutti i problemi attinenti una linea di condotta rivoluzionaria”. L’organizzazione è a livello territoriale, articolata in nuclei e attivi, con una direzione, la commissione politica. Le basi teoriche e culturali del progetto affondano in una lettura, originale e adeguata al periodo storico, dell’operaismo italiano (a partire da una rilettura degli scritti di Karl Marx), da Raniero Panzieri ad Antonio Negri.
Nato negli anni ’60, muovendo dai Quaderni rossi, l’operaismo interpreta e sostiene le lotte degli operai, dal “salto della scocca” all’Alfa Romeo, al biennio di lotte ’68-’69 dell’operaio-massa e del movimento studentesco, alle lotte proletarie sul territorio che investiranno l’assetto dello sfruttamento e del comando capitalistici. Questa formazione di provenienza operaista si arricchirà facendo propri gli insegnamenti delle due principali esperienze storiche del movimento comunista internazionale del Novecento, il leninismo e il maoismo.
Da questi tre filoni verrà impostato un metodo politico-organizzativo che sarà il tratto distintivo della nuova organizzazione: agire da partito senza essere (ancora) un partito. Il territorio viene letto e “forzato” come un insieme di zone omogenee. Nasceranno così il Collettivo Politico Padova Nord, il Collettivo Politico Padova Centro e il Collettivo Politico Padova Sud. Per un periodo iniziale, con lo scopo di impostare e avviare un intervento comune dei tre Collettivi, verrà formata una Commissione fabbriche-territorio. L’analisi delle contraddizioni di classe e degli sviluppi dello scontro operai-capitale darà vita a una linea politica di intervento che all’operaio di fabbrica affiancherà le nuove figure proletarie riassumibili nel concetto di operaio sociale e di fabbrica diffusa.
L’intervento sul territorio, nelle zone omogenee, porterà avanti la battaglia politica sul programma all’interno dell’intera composizione politica di classe, nella fabbrica, nei paesi, nei quartieri cittadini. Al sostegno e all’organizzazione delle lotte per aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro si affiancherà la lotta sul salario sociale, contro la disoccupazione, la precarietà, l’aumento del costo della vita.

Quindi battaglia per i prezzi politici delle merci e dei servizi, per una pratica di illegalità di massa che doveva determinare salti organizzativi di riappropriazione riproducibili sul territorio. La proposta e la pratica dei Coordinamenti operai territoriali voleva superare i limiti dei Consigli Operai interni alla fabbrica e rompere la divisione tra operai occupati e disoccupati, tra lavoratori col posto fisso e precari, tra fabbrica e paese, per rompere l’isolamento della realtà femminile di fabbrica e del proletariato femminile tradizionalmente escluso da una qualsiasi fonte di reddito e dai servizi sociali.
Dal Coordinamento operaio di zona alla Ronda operaia e proletaria territoriale, che a partire da una ricomposizione omogenea del proletariato doveva eliminare la divisione e la distanza tra operai di fabbrica e proletari di paese: dalle ronde contro gli straordinari in fabbrica alle ronde per i prezzi politici, dalle ronde che portavano i precari e disoccupati davanti ai cancelli di fabbrica alle ronde che vedevano gli operai uscire dalla fabbrica e lottare anche nei paesi, non solo per aumenti salariali nominali ma anche per aumenti del salario sociale complessivo. Il programma dei Collettivi si articolerà anche nella proposta dei Gruppi sociali territoriali, nei quartieri e nei paesi.
Il Gruppo sociale doveva essere un primo livello di aggregazione proletaria, soprattutto giovanile, su obiettivi, pratiche, parole d’ordine che diventavano immediatamente strumenti di lotta politica e di crescita organizzativa sul territorio.
L’Università sarà un altro terreno importante per l’intervento, non più area di parcheggio per una futura forza-lavoro ma terreno di scontro e di contraddizione sociale, “fabbrica diffusa della scienza e della conoscenza”. Lo studente era considerato dai Collettivi un proletario che quotidianamente doveva risolvere problemi vitali, bisogni sociali e politici insopprimibili (il mangiare, il dormire, il vestire, il viaggiare, ecc. ) oltre allo studio e al conseguimento del titolo di studio. Fin da subito entrava a far parte di quel settore di classe sempre più vasto del lavoro nero, sottopagato, part-time, a cottimo.
Si formeranno Comitati di lotta dei senza-casa, Comitati per le mense sociali a prezzo politico, Comitati contro il caro trasporti. Le forme di lotta saranno le occupazioni, le ronde, i blocchi stradali. La critica alla didattica nella scuola e nell’università sarà diretta e gestita dal Comitato Interistituto e dal Comitato Interfacoltà con occupazioni e seminari autogestiti.
Nei paesi e nei quartieri si svilupperà un movimento di lotta contro il caro prezzi dei generi alimentari, degli affitti e dei trasporti urbani ed extraurbani con il blocco delle corriere, con mercatini sociali, con espropri dei supermercati e distribuzione dei generi alimentari tra i proletari nei quartieri.

Nel 1976 il progetto politico, nato a Padova, si espanderà in altre realtà della regione con i Collettivi Politici Veneti per il Potere Operaio. Una rete di situazioni territoriali reali e coordinate da un Esecutivo. I compagni di quelle realtà daranno vita ai Collettivi Politici Vicentini per il Potere Operaio (di Vicenza, di Thiene, di Schio, di Montecchio Maggiore, e successivamente di Bassano), al Collettivo Politico di Rovigo per il Potere Operaio, al Collettivo Politico di Pordenone per il Potere Operaio, al Collettivo Politico di Mestre per il Potere Operaio che nel 1978, con altri compagni di Marghera, Chioggia e Venezia, darà vita ai Collettivi Politici Veneziani per il Potere Operaio.
La pratica dell’antifascismo militante per i compagni/e di Potere Operaio e, poi, dei Collettivi Politici sarà un terreno costante di intervento e di crescita politica. Anche per i Collettivi Politici, come per altre organizzazioni rivoluzionarie in quegli anni, la lotta armata sarà una scelta strategica ma, a differenza ad esempio delle Brigate Rosse, il concetto di partito armato clandestino sarà estraneo alla formazione culturale e alla pratica politica di questa organizzazione. Per i Collettivi Politici la rivoluzione comunista sarebbe stata possibile solo lavorando alla luce del sole e l’illegalità doveva essere di massa e sempre relazionata all’accumulo della forza in senso politico e materiale, con una militanza dentro le situazioni, per promuoverle, senza nascondere la propria identità di comunisti.
La violenza esercitata contro i fascisti, i padroncini, il comando degli apparati dello Stato e “ i servi del padrone” doveva avere, aveva, questo segno. Quindi l’omicidio politico era totalmente estraneo alla pratica politica dei Collettivi. Su questo terreno i Collettivi condurranno fin dagli inizi una dura battaglia politica con i compagni delle organizzazioni combattenti clandestine.
Come diceva il compagno Mao tse tung, “la politica comanda sempre sul fucile”.
Per i Collettivi Politici Veneti, quindi, l’uso della forza e l’illegalità di massa erano legati all’attività politica alla luce del sole e finalizzati alla creazione ed estensione di un effettivo contropotere operaio e proletario. Dentro questo programma politico dal 1975 al 1979 saranno lanciate una decina di campagne politico-militari a livello cittadino e regionale chiamate dalla stampa “notte dei fuochi”.
Le diverse pratiche dell’uso della forza saranno rivendicate da diversi livelli organizzativi: Organizzazione operaia per il comunismo, Proletari comunisti organizzati, Ronde armate proletarie, Fronte comunista combattente. Nel 1976 i Collettivi Politici entrano nella gestione di radio Sherwood di Padova, radio del movimento e dell’autonomia operaia. La radio aprirà due succursali a Mestre e a Vicenza-Thiene. Nell’ottobre del 1976 e nel marzo del 1977 i Collettivi pubblicano il giornale “ Per il potere operaio”. Nell’ottobre del 1978 esce il primo numero di “Autonomia” che sarà il “giornale” dell’organizzazione negli anni successivi.
Dal 1977 ai Collettivi farà riferimento la libreria Calusca , progetto nato a Milano per garantire la diffusione del materiale di movimento a livello nazionale.

Collettivi entreranno nella gestione di “Cinema 1”, un’organizzazione universitaria che per gran parte degli anni ’70 avrà una ricca e interessante programmazione cinematografica. I Collettivi parteciperanno anche alle gestione della “Punti Rossi”, un sistema di distribuzione del materiale di movimento. Radio, giornale, cinema, libreria e distribuzione saranno terreno di gestione e intervento dal 1978 del Centro di Comunicazione Comunista Veneto, una struttura dei Collettivi e una delle esperienze più avanzate in Italia, dove veniva coniugata la diffusione della produzione scritta (Autonomia, Calusca, Punti Rossi) con quella orale (radio Sherwood).
I Collettivi metteranno in cantiere anche una “televisione di movimento”, ma il progetto non si realizzerà a causa della campagna di repressione e arresti iniziata il 7 aprile 1979. L’esplosione del Movimento del ’77 con la sua ricchezza e le sue contraddizioni spinge i Collettivi Politici Veneti a porre il problema, a livello nazionale, della necessità dell’ Organizzazione dell’Autonomia Operaia.
La proposta verrà lanciata, con i compagni dell’importante area di Rosso, con il primo numero, settembre ’77, di Rosso per il potere operaio. L’indicazione a tutte le componenti dell’Autonomia Operaia sarà di praticare un programma di lotte centrato sui temi della riduzione dell’orario di lavoro, della spesa pubblica, della repressione e del carcere, dello Stato nucleare e la produzione di morte: il “programma delle quattro campagne”.
La proposta sarà rivolta in particolare ai compagni dei Comitati autonomi operai di via dei Volsci di Roma (i Volsci), un’importante realtà politico-organizzativa, simile per programmi, pratica e radicamento ai Collettivi Politici Veneti. I Volsci non condivideranno questa proposta federativa.

Alla fine del 1978 e gli inizi del 1979 i Collettivi Politici Veneti, preso atto dell’impasse di un progetto organizzativo a livello nazionale, ripiegheranno sul loro territorio con la proposta del Movimento Comunista Veneto, per costruire l’Autonomia Operaia Organizzata per il contropotere, come terreno strategico dopo il radicamento territoriale raggiunto a livello regionale. Se avesse funzionato sarebbe stato riproposto alle altre situazioni territoriali nazionali come Movimento Comunista Organizzato. Il 1979 è l’anno della risposta dello Stato e del sistema politico, centrato sull’alleanza strategica PCI-DC, alle lotte operaie e proletarie e al radicamento politico organizzativo dell’Autonomia Operaia Organizzata.
Il 7 aprile 1979 viene scatenata la prima campagna repressiva, la seconda l’11 marzo 1980. Centinaia le compagne e i compagni coinvolti a vario titolo. L’11 aprile 1979 muoiono in un’esplosione a Thiene (VI) tre compagni dei Collettivi Politici Vicentini (Antonietta Berna, Angelo Dal Santo, Alberto Graziani) mentre preparavano un’azione contemplata nelle quattro campagne politico-militari. Lorenzo Bortoli, compagno di Antonietta Berna, sarà arrestato e sottoposto a violente pressioni fisiche e psicologiche che lo spingeranno al suicidio.
Gli arresti dell’11 marzo 1980 porranno fine al percorso politico-organizzativo, come progetto, così come si era sviluppato nella seconda metà degli anni. I militanti dei Collettivi Politici Veneti subiranno sei gradi di giudizio, carcere, latitanza, centinaia di condanne. La decisione di affrontare i processi per ribadire la loro dignità di comunisti e di accettare dentro il processo la difesa sui fatti specifici contestati fu collettiva.
Gli imputati detenuti, a piede libero o latitanti, si presentarono davanti ai giudici e all’opinione pubblica con un documento/memoria difensiva collettivo. Il documento “Io ricordo” rivendicava con orgoglio tutta la loro storia politica. Gli imputati furono affiancati da un collegio difensivo coeso e dal Comitato 7 aprile-11 marzo, formato dai familiari dei detenuti e dei latitanti, con una propria identità e una presenza politica costante a Padova e nel Veneto, per tutta la durata dei processi, fino all’87. I compagni e le compagne dei Collettivi Politici Veneti hanno sempre criticato e combattuto anche all’interno delle carceri la degenerazione politica del cosiddetto “combattentismo clandestino”. Così come non hanno mai aderito alla proposta della “dissociazione politica” avanzata nel 1982 dai detenuti della cosiddetta “area omogenea di Rebibbia” (documento dei 51).

APPELLO
Facciamo appello alle compagne e ai compagni che hanno condiviso la nostra storia a tutti i livelli e che vogliono arricchire questo sito con un loro contributo scritto/orale/video, raccontando le proprie esperienze, di contattarci a questo indirizzo email:collettivipoliticiveneti@archivioautonomia.it