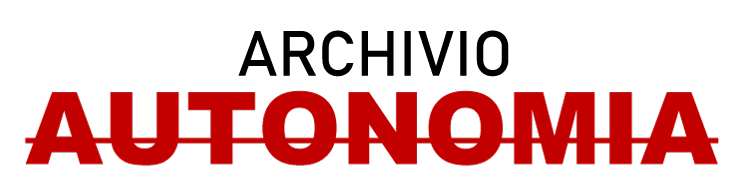Autonomia operaia. Esperienze di giornalismo operaio

Ninetta Zandegiacomi, Autonomia operaia. Esperienze di giornalismo operaio, Bertani editore, Verona 1974
Nel 1970 un gruppo di consigli di fabbrica comincia a pubblicare propri giornali e bollettini. Nei due anni successivi il loro numero aumenta parallelamente con l’estendersi e il consolidarsi dei nuovi organismi di fabbrica. Si manifesta così e in breve si afferma una forma di giornalismo del tutto nuovo, anche rispetto a tutti gli altri giornali che precedentemente erano stati redatti nella fabbrica e per la fabbrica o concepiti per un pubblico di lettori operai.
I caratteri di novità sono dati anzitutto dal tipo di gestione unitaria e dalla partecipazione di operai e impiegati alla preparazione e alla raccolta del materiale pubblicato. Non si tratta più, oltretutto, salvo rare eccezioni, di scritti che vengono dall’esterno. Perciò la pubblicazione di fabbrica non riproduce meccanicamente i livelli di mediazione sui cui si attesta il processo unitario ai vertici del sindacato nelle posizioni ufficiali.
La stessa natura del consiglio, che è rappresentante diretto di tutti i lavoratori occupati in un’azienda, che è quotidianamente e direttamente esposto ai successi e ai contraccolpi di una situazione conflittuale, dà al suo giornale un carattere d’immediatezza nel rispecchiare, oltre che gli avvenimenti, le tendenze, le discussioni, i rapporti interni alla fabbrica. Di conseguenza esso è anche lo specchio più nitido del grado di maturazione della collettività operaia che vi opera e della cultura che vi si esprime a livello politico, sia nella partecipazione ai conflitti sindacali e di lavoro, sia nelle proposte alternative sui problemi di politica generale.
Questo carattere di novità è assicurato dalla stessa organizzazione che i consigli danno in genere al lavoro di impostazione e di redazione dei loro giornali.
Del giornale e responsabile un’apposita commissione, ma tutto il consiglio legge e discute il materiale prima di passarlo alla stampa. Raramente si utilizzano collaborazioni esterne, chi scrive, nella maggior parte dei casi, è membro del consiglio. Gli interventi di base, di singoli lavoratori o ili interi collettivi di reparto, non sono rari. spesso vengono previsti sistematicamente nelle pagine riservate agli «interventi dai reparti» o al dibattito…
Criminalizzazione della lotta di classe

AA.VV., Criminalizzazione della lotta di classe, Bertani editore, Verona 1975
[…] Vanno… salgono sulla loro macchina… vanno verso il luogo fissato dell’appuntamento. Lì parcheggiano l’automobile, scendono e si mettono a passeggiare; poco dopo sul luogo fissato dell’appuntamento, che era vicino al cinema «Vox» (!), poco dopo vedono il pulmino parcheggiato più in là e Osvaldo che aspetta.
Salgono sul pulmino con Osvaldo e si dirigono verso Segrate. Il… il… luogo dove si dirigevano non era loro noto, ma era noto sin dal sabato precedente l’obbiettivo. Cioè l’obbiettivo della serata. Infatti ne discussero con lui sabato stesso in presenza di altri compagni. A loro quindi era noto cosa andavano a fare, ma non dove andavano a farlo.
Nella serata di sabato avevano espresso, insieme agli altri, la propria opinione circa il tipo di obbiettivo che dovevano mettere in atto, ma Osvaldo era stato in grado di imporre lo stesso, comunque, la cosa. Quella sera si trattava di una opposizione di tipo psicologico, ed in parte anche politico; infatti accusa i due di mancanza di coraggio e di cattiva volontà.
Il giorno precedente il 13, li mandò infatti in giro intorno Milano, verso, dalle parti, in direzione di Bergamo per ricercare dei tralicci, con il compito di localizzarli, misurarli, calcolarne le dimensioni, e per metterli insieme alla lista di possibili obbiettivi della giornata.
I due infatti fecero tutto questo, andarono verso Bergamo, e individuarono un grossissimo traliccio di cui presero le misure. Si infangarono anche, solo che… Osvaldo poi disse che il traliccio era troppo distante da Milano, troppo lontano e che lui aveva già provveduto a questo. Sembra che volesse semplicemente mettere alla prova la… volontà di collaborare dei due amici. Loro di questo in fondo ne erano da un lato coscienti e dall’altro tendevano a dimostrare la loro volontà. […]
(Dalla Requisitoria Definitiva nei Processi Feltrìnelli – Brigate rosse del Giudice Viola – Procura della Repubblica di Milano)
[…] Che si tratti di un’associazione di natura politica e segreta, costituita alfine di combattere dalla clandestinità, e con azioni violente, una lotta rivoluzionaria contro la società capitalistica e borghese, per farne esplodere le contraddizioni e giungere, utilizzando la lotta armata, alla disgregazione dello stato in cui detta società si impersona, lo dice l’abbondantissima produzione ideologica delle Br e lo confermano le singole azioni criminose poste in atto con un crescendo allarmante, ma anche con una rigida coerenza.
Non è qui il caso di rifarsi alle origini del movimento, che comunque sono state esaminate e illustrate in un’altra istruttoria [v. la Requisitoria del Giudice Viola, n.d.r.], svolta a Milano, e della quale, in certo senso, questa rappresenta la continuazione temporale e logica. D’altronde sarà compito piuttosto del sociologo e dello storico l’identificazione dei contributi ideologici che i più preparati rappresentanti delle Br hanno tratto da dottrine politiche oramai secolari quali il marxismo o il sindacalismo rivoluzionario, o da altre più recenti esperienze, dalla rivoluzione cinese alle sommosse del ’68, dalla guerriglia urbana dei «Tupamaros» al terrorismo delle Baader-Meinhof. […]
(Dalla Requisitoria sulle Brigate rosse del Giudice Caccia – Procura Generale della Repubblica di Torino)
Bologna marzo 1977… fatti nostri…

AA.VV., Bologna marzo 1977 …fatti nostri…, Bertani editore, Verona 1977
«Non c’è una storia in questo libro, pagina uno non è madre o causa di pagina due, semplicemente viene prima: se qualche sociologo è tra voi, inizierà il libro dalla fine, quello è l’ordine sociologico, ma… il libro inizia come nella nostra testa, con la morte di Francesco, gli scontri le barricate il fuoco: dove abbiamo iniziato questa fase della nostra vita…».
Qui, nel rifiuto delle spiegazioni e nel bisogno della comunicazione, sta il nodo non solo di questo libro ma dei fatti, del periodo storico e politico in cui libro e fatti si inscrivono: questo 1977 duro e opaco più di ogni altro recente anno… L’emarginazione non è, qui, puro dato sociologico: si fa vissuto e azione; la stessa frattura con la città consumata nel precipitare della lotta, non è esterna alla consapevolezza. Utopicamente, i ragazzi di Bologna se ne fanno un’arma, momento di invenzione e di nuova provocazione: «Questo libro è un discorso senza soggetto… una città invisibile, che scivola sotto, che scappa dal tetto, assente dagli specchi ufficiali della stampa, dai comizi scritti letti e ripetuti… noi guardiamo la città invisibile sulla quale si è adagiata Bologna rossa e bottegaia… irritata perché è stato turbato lo spettacolo della sua propaganda»…
Le vetrine rotte sono un altro modo: se ne può discutere a lungo, certo è che quegli stessi ragazzi, una settimana prima, invadevano i marciapiedi, durante i cortei, per parlare, discutere, coinvolgere, senza deleghe e gerarchie, rifiutando il rituale della politica.
Che la contestazione del ’77 sia ancor meno «facile» di quella del ’68, è indubbio: pubblicando questo libro, accettiamo una sfida, che a nostra volta ribaltiamo sui lettori: È POSSIBILE CAPIRE? È possibile (per di più di fronte ad un soggetto collettivo che si rifiuta di darne una) una interpretazione politica non di comodo – né in una direzione né nell’altra? Sette, otto mesi tra i più infuocati del dopoguerra, bisogni e desideri, azioni politiche e politiche gestuali, scelte e non-scelte, tutto questo può accogliere e sviluppare di nuovo una possibilità positiva, una linea di condotta, insomma uno sbocco politico reale?
Il diritto all’odio. Dentro/fuori/ai bordi dell’area dell’autonomia

Gabriele Martignoni, Sergio Morandini, Il diritto all’odio. Dentro/fuori/ai bordi dell’area dell’autonomia, Bertani editore, Verona 1977
Riprendere in mano i fili della lotta di classe nel momento storico che ci appartiene, riprendere in mano i profili storici dei soggetti reali che si apprestano a distruggere la sceneggiatura del dominio vuoi dire. più che contarsi, fare i conti col denominatore minimo, col soggetto nascosto che va configurandosi come detonatore dello scontro.
Nelle minime tracce più avanti presentate, nelle analisi e nei documenti a prima vista stonati tra loro, abbiamo cercato di esprimere, in una scelta tutt’altro che casuale, un tentativo che riesca a sintetizzare il ventaglio reale su cui il movimento realizzerà, nel breve tempo a venire, il nuovo attacco al dominio.
La traccia che questi appunti lasciano complessivamente sul materiale, riguarda alcune precisazioni indispensabili sulla conoscenza, sulla scienza, sul quotidiano, sulla tendenza e sulla scomposizione/ricomposizione di classe; il filo eversivo che lega invece i documenti di ogni sezione e le sezioni tra di loro, percorre i luoghi in cui le discriminanti di classe si fanno intransigenti.
Il soggetto storico che ovunque scompare e sul quale la classe dovrà prima o poi confrontarsi è il proletariato giovanile, la cui figura sociale accede alla storia estraniata dalla produzione, dalla militanza, dalle lotte del ’68, dalla dinamica dei gruppi e, quel che più conta, frustrato nei bisogni e nei desideri reali soffocati quotidianamente attraverso l’emarginazione, la disoccupazione e la criminalizzazione.
Deve essere chiaro, comunque, che il nostro lavoro non ha voluto raccogliere enciclopedicamente tutte le testimonianze sviluppate dentro, fuori e ai bordi dell’area dell autonomia, ma rivelare i percorsi e dispiegare la sostanza dell’area attraverso una scelta di utilità che percorresse al massimo il gergo complessivo del nuovo attacco al potere.
A questo gergo, al nuovo modo d’essere del coro/classe, appartiene il desiderio di giustiziare i luoghi comuni, gli aristocraticismi settari, il nodo fittizio in cui si ammazza (scontandolo e ignorandolo) il filo rosso dell’insurrezione che sputa sul ghigno di ogni penitenziario sociale e di ogni ideologia penitenziaria, il suo diritto all’odio.
Dell’innocenza, Interpretazione del ’77

Franco Berardi, Dell’innocenza, Interpretazione del ’77, Agalev edizioni, Bologna 1977
Ora:
Franco Berardi (Bifo), Dell’innocenza: 1977 l’anno della premonizione, Ombre Corte, Verona 1997
Il Settantasette può essere considerato per molti aspetti l’anno di transizione all’epoca del disincanto. Le grandi ideologie che hanno animato il ventesimo secolo conoscono in quell’anno il loro punto di massima combustione, e anche l’inizio del loro dissolvimento.
Pensiero debole, postmodernità, teoria dell’implosione: questi concetti filosofici emergono e fanno la loro prova in quel periodo inquieto, nel quale, per la prima volta, la società ha sperimentato la forza della rivolta e, per la prima volta, ne ha visto l’impotenza, l’inefficacia. Questo libro è una rivisitazione delle problematiche del movimento del Settantasette, in una prospettiva al tempo stesso disperata e felice.
L’innocenza – come la saggezza di cui parla William Blake – «ha visto tutto e nulla dimenticato, eppure sa vedere ogni cosa come se fosse per la prima volta». Questo libro uscì la prima volta nel decennale del movimento insurrezionale, autonomo e creativo.
Oggi lo ripubblichiamo con l’aggiunta di una lunga prefazione che propone di considerare quell’anno come la premonizione di un processo che, lungi dall’essere esaurito, continua a svolgersi sotto i nostri occhi.
Simulazione e falsificazione
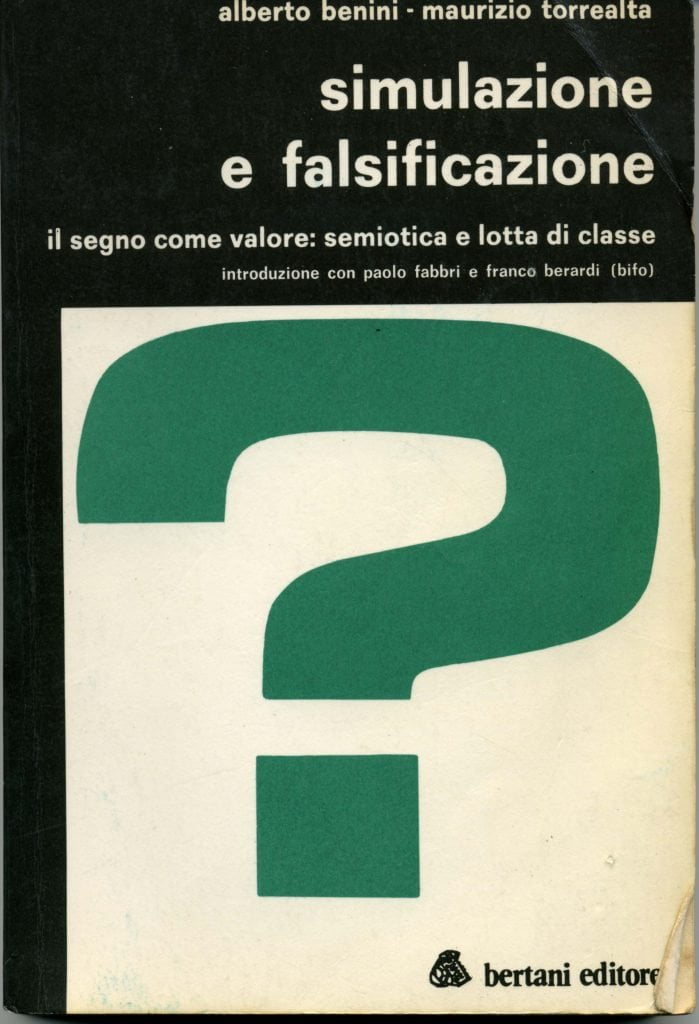
| Alberto Benini, Maurizio Torrealta, Simulazione e falsificazione. Il segno come valore: semiotica e lotta di classe, Bertani editore, Verona 1981 Aprire la serratura di una macchina con una sottile striscia di metallo, occupare una città per pochi giorni, battere moneta autonomamente, rapinare le banche tramite il calcolatore, sono tutte operazioni che hanno a che fare con l’ordine semiotico e le sue necessarie possibilità simulatorie. Strutturare in teoria queste operazioni parziali, che hanno comunque fatto parte del sapere autonomo di strati sociali di classe, è una esigenza incalzante per chi crede che nelle città la guerra è sempre esistita, proprio nella pace delle leggi. Le radici e gli sviluppi di questo approccio allo studio della simulazione e della falsificazione, rimandano e conducono, da una parte, alla più squisita esperienza paradossale della scuola sofista, e dall’altra alle teorie più sofisticate delle strategie antiguerriglia. Anche le recenti azioni terroristiche ripropongono con forza l’esigenza di approfondire il rapporto tra spettacolo e guerra, e più in generale tra ordine semiotico e simulazione. Questo libro riporta, tra l’altro, materiale inedito sui crimini effettuati tramite il calcolatore negli Stati Uniti, e sulle forme di organizzazione tecnologica che là il movimento si è dato da più di dieci anni. Esso è frutto di una ricerca svolta collettivamente nell’ambito del corso di comunicazioni di massa presso il corso del DAMS a Bologna. Alberto Benini è nato nel ’50 in campagna: fratello dell’oramai famosissimo comico, seguì a Paris, nel Kentucky, i corsi alla scuola fondata da Piper, il più grande falsario di tutti i tempi. Divenne un’importante spia industriale con lo pseudonimo di Sanluca. Maurizio Torrealta è nato nel ’49 a Dublino da madre italiana e padre cosacco, ha soggiornato a lungo a Bahia, che ha lasciato per Napoli, città-cardine nella sua formazione culturale e professionale. Assolto con formula piena dai tre processi intentatigli per falso, incontrò il Benini mentre questi stava scontando 4 anni al DAMS. Attualmente vive un po’ qua un po’ là: non ha mai creduto molto nel nome proprio. |
Giornate nazionali di mobilitazione contro i missili e la presenza NATO in Italia
archivio Federico Sorgato